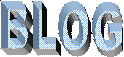“I
risultati che hanno seguito il Concilio sembrano
crudelmente
opposti alle attese di tutti [..]
Ci
si aspettava un balzo in avanti e ci si è invece trovati
di
fronte a un processo progressivo di decadenza. [..]
Vie
sbagliate [..] hanno portato a conseguenze
indiscutibilmente
negative” (J. Ratzinger
in V. Messori,
Rapporto
sulla fede, Ed. Paoline
1985, 27 s.)
***
Che esista una crisi nella Chiesa a partire dagli anni Sessanta
del Novecento è sotto gli occhi di tutti e non staremo ad indugiare su questo
crudele fatto, attestato dal crollo subitaneo e fortissimo di tutti gli
indicatori, come vocazioni, percentuali di persone che si dicono cattoliche,
pratica religiosa, accesso ai sacramenti, e così via: Giovanni Paolo II ha
coniato in proposito l’espressione di apostasia
silenziosa (Ecclesia in Europa, 9). Sono elementi, certo,
quantitativi, ma ormai nessuno o quasi si azzarda più a sostenere la favoletta
che in termini qualitativi vi sia stato progresso, dato che è difficile
sostenere che siano migliori, più motivati e meglio formati, rispetto a ieri, i
decimati frequentatori delle parrocchie, la cui età media tra l’altro è in
costante aumento per assenza di trasmissione della fede ad ampi strati delle
giovani generazioni.
La domanda che si pone spontanea è
allora: vista l’oggettiva concomitanza temporale tra l’esplodere della crisi e
la conclusione del Concilio Vaticano II, si deve ritenere quest’ultimo causa,
ovviamente involontaria, di tanto disastro? Si può, in altri termini, applicare
il principio, pur in logica fallace, post
hoc ergo propter hoc? O dobbiamo invece ascrivere la frana ad elementi
esogeni ed esterni, come la rivoluzione dei costumi degli anni Sessanta, il
Sessantotto, il secolarismo o il marxismo, ecc., e magari cercare di perpetuare
l’apologia del Concilio se non più (perché i dati impietosi e cocciuti rendono
ormai risibili quelle definizioni) come nuova Pentecoste e primavera della Chiesa
(già Paolo VI, in una famosa omelia, diceva che dopo il
Concilio, anziché un giorno di sole, eran venuti tempesta, buio e incertezza),
almeno come rimedio palliativo e “toppa” ad una tendenza antireligiosa che
sarebbe stata ancora più devastante senza le aperture conciliari?
La questione è oggetto di studio in campo
sociologico e si può ritenere che si sia giunti a conclusioni sufficientemente ferme
e mature. Consigliamo vivamente di leggere in proposito il bellissimo
contributo di uno dei più grandi sociologi delle religioni, Massimo Introvigne, «Il rumore confuso dei clamori ininterrotti»,
pubblicato dal sito Cesnur. Noi vogliamo in questa sede
ripercorrere, in estrema sintesi divulgativa, le conclusioni di questo scritto,
estratto di un più ampio lavoro.
In primo luogo, dobbiamo chiarire che non ha molto senso
“fare il processo” al Concilio. Ce lo vieta innanzi tutto
Orbene, al quesito che ci siamo posto la
risposta dei sociologi è affermativa: causa della crisi del cattolicesimo è
stato proprio il Concilio per come è
stato recepito e percepito (non quindi, ripetiamo ancora, il Concilio in sé
per come è, ma potremmo dire il Post-Concilio, la mentalità progressista ‘di
rottura’ ispirata ad un abusivo Spirito del Concilio, che è divenuta
maggioritaria negli anni immediatamente successivi al 1965).
Per giungere a tali conclusioni, gli
studi citati da M. Introvigne si sono appuntati su dati statistici: ad esempio
nel periodo 1965-1995 le vocazioni sacerdotali e quelle religiose femminili
sono calate nei paesi nordeuropei e negli Usa in percentuali variabili tra il
50 e l’80 per cento; per contro in Spagna e Portogallo (che fino al 1975 furono
soggetti a dittature di destra che si frapposero all’applicazione
dell’aggiornamento postconciliare) il calo comincia solo dopo il ritorno alla
democrazia e il recupero, da parte delle istanze ecclesiali iberiche, delle
posizioni arretrate rispetto alle chiese più “avanzate” del resto d’Europa.
Allargando lo sguardo al di fuori del
cattolicesimo, si nota inoltre come aumenti la diffusione delle religioni
maggiormente integraliste e rigoriste, quali i pentecostali; senza considerare
l’Islam, che conosce una spettacolare espansione in concomitanza con il ritorno
a posizioni senza dubbio antemoderne (si pensi al velo femminile o
all’applicazione della sharìa: pratiche quasi obsolete alcuni decenni fa, almeno
nei centri urbani mediorentali, ed oggi sempre più all’ordine del giorno). Per
contro le religioni più liberal,
lassiste e ritenute “al passo coi tempi”, sono in gravissima crisi, anche
peggiore del cattolicesimo: la chiesa luterana di Stato svedese, che da tempo
prevede un rituale di benedizione di unioni omosessuali, conosce una pratica
del 3%; la chiesa anglicana, poi, è sull’orlo del collasso e dello scisma per
la questione dell’ordinazione di gay “in attività” oltreché, in misura minore,
per l’ordinazione femminile: e anche qui è interessante notare la relativa
maggior vitalità delle province anglicane africane, più rigoriste, rispetto
all’ala più liberale rappresentata dagli episcopaliani americani, ridotti a
poco più di due milioni (episcopaliano è il vescovo omosessuale Gene Robinson,
divorziato dalla moglie e convivente con un uomo col quale si è da poco sposato
civilmente, dichiarando di aver sempre sognato d’essere una june bride, qualcosa di analogo a una
“sposa di maggio”: v. riferimenti qui).
Insomma: pare evidente che sussista una proporzione inversa tra
le posizioni “moderne” e al passo coi tempi rispetto agli indicatori di
vitalità di una religione. Ossia, in altri termini, se una fede è severa e
rigorista, attira più fedeli. Eppure si sente spesso ripetere l’opinione
secondo cui il Cattolicesimo perde colpi perché non è in sintonia col mondo
attuale e mantiene posizioni anacronistiche e premoderne, soprattutto in tema
di morale sessuale (si pensi alle tematiche del divorzio, dell’aborto, dei
mezzi anticoncezionali, in cui effettivamente ben pochi, anche tra i cattolici
dichiarati e praticanti, seguono fino in fondo il magistero). Come si spiega
questa apparente contraddizione, che sembra manifestare una sorta di
“masochismo” dei fedeli, contenti solo quando la loro religione li costringe a
posizioni conflittuali con l’orientamento permissivo maggioritario della
società?
A questo paradosso dà una spiegazione
razionale la sociologia delle religioni. Mentre alcuni decenni fa si pensava
che il successo di una religione dipendesse dalla mentalità dei fedeli, sicché
in una società secolarizzata avrebbero retto meglio quelle religioni che agli
imperativi della secolarizzazione, e quindi alle opinioni della gente, si
fossero in qualche modo adattate o aggiornate, successivamente tale tesi,
denominata vecchio paradigma, è stata
superata e perfino rinnegata dal suo primo propugnatore (Harvey Cox, il quale
la propose in un influentissimo testo del 1965 intitolato La città secolare, ma trent’anni dopo riconobbe l’infondatezza
delle premesse sociologiche e fattuali su cui la sua tesi era fondata).
Si è scoperto infatti che, dal lato dei
fedeli, la domanda di senso religioso
resta sostanzialmente costante, mentre quel che cambia è, sul lato dell’offerta, quanto una Chiesa o religione
organizzata è in grado di proporre (cosiddetto nuovo paradigma); ed è precisamente questo che determina la
crescita o la crisi di una religione. Infatti nell’ultimo mezzo secolo non è
diminuita globalmente la percentuale di persone credenti: semplicemente, molte
hanno cambiato fede (alle perdite della Chiesa cattolica e delle denominazioni
protestanti storiche, e ormai liberaleggianti, ha corrisposto non l’aumento di
atei ma la speculare crescita di denominazioni più fondamentaliste come i
pentecostali, gli evangelici, i Testimoni di Geova e i Mormoni). Se fosse
invece vera la tesi del ‘vecchio paradigma’, tutte le religioni indistintamente
avrebbero dovuto soffrire per la secolarizzazione, e semmai resistere con
minori perdite proprio le religioni più aperte alle evoluzioni permissive della
società.
Ma se queste constatazioni descrivono la
situazione per come è, esse non individuano ancora il meccanismo per cui
guadagnano le religioni che si pongono contro le tendenze generali della
società. La spiegazione è nella teoria delle nicchie: la domanda religiosa si
indirizza verso una di queste cinque ‘nicchie’, distinte a seconda del loro
grado di conflittualità decrescente con la mentalità secolarizzata:
ultra-rigorosa, rigorosa, centrale, progressista e ultra-progressista. La
sociologia (stiamo sempre seguendo lo studio di M. Introvigne) ha verificato
che la distribuzione dei fedeli nelle varie nicchie è diseguale: mentre nelle
due nicchie estreme si collocano in pochissimi (quella ultra-rigorosa è di
solito la nicchia di una nuova religione nel suo stadio iniziale,
tendenzialmente ‘settario’), il grosso dei fedeli rientra nei due segmenti
“rigoroso” e “centrale”. Relativamente pochi si collocano invece nella nicchia
“progressista” e pochissimi, come detto, in quella ultra-progressista. Verrebbe
allora da chiedersi come mai la società moderna sia così progressista e
secolarizzata, allorché la corrispondente nicchia religiosa è poco frequentata:
il fatto si spiega semplicemente perché i fautori di tale mentalità ‘moderna’
nella maggior parte dei casi sono del tutto a-religiosi e non rientrano perciò
in alcuna delle nicchie elencate; sono i cosiddetti “laici” (ma sarebbe meglio
dire laicisti), privi di affiliazione con qualsiasi chiesa e in genere molto
influenti, anche se minoritari, nella società e nei “salotti buoni” dei mezzi
di comunicazione, sì da poter determinare l’orientamento generale verso un sempre
maggior secolarismo. E’ un dato di fatto inoltre che le nicchie progressista e
ultra-progressista subiscono una continua erosione verso l’esterno, ossia molti
di coloro che le componevano finiscono con l’abbandonare del tutto la
dimensione religiosa ed escono dal “sistema delle nicchie” (si pensi ad esempio
a quanti preti, laici e religiosi “impegnati” e progressisti hanno lasciato
La conseguenza di queste constatazioni
sociologiche è che una religione prospera finché la sua offerta di senso
religioso è in grado di soddisfare i fedeli rientranti nelle nicchie rigorosa o
centrale; entra in crisi se invece l’offerta diviene appetibile piuttosto per
la nicchia progressista o, peggio ancora, per quella ultraprogressista.
Secondo una convincente ricostruzione
sociologica, sempre riportata da M. Introvigne nello studio qui compendiato,
Ecco, quindi, la conclusione: qualcosa è
andato veramente storto ed ha portato alla crisi attuale della Chiesa: non una
presunta ritrosia nell’abbracciare i nuovi valori dominanti della società
secolarizzata (come vogliono certe datate ricostruzioni, come quella della
Scuola di Bologna di Alberigo, che rimproverano a Paolo VI di avere, specie con